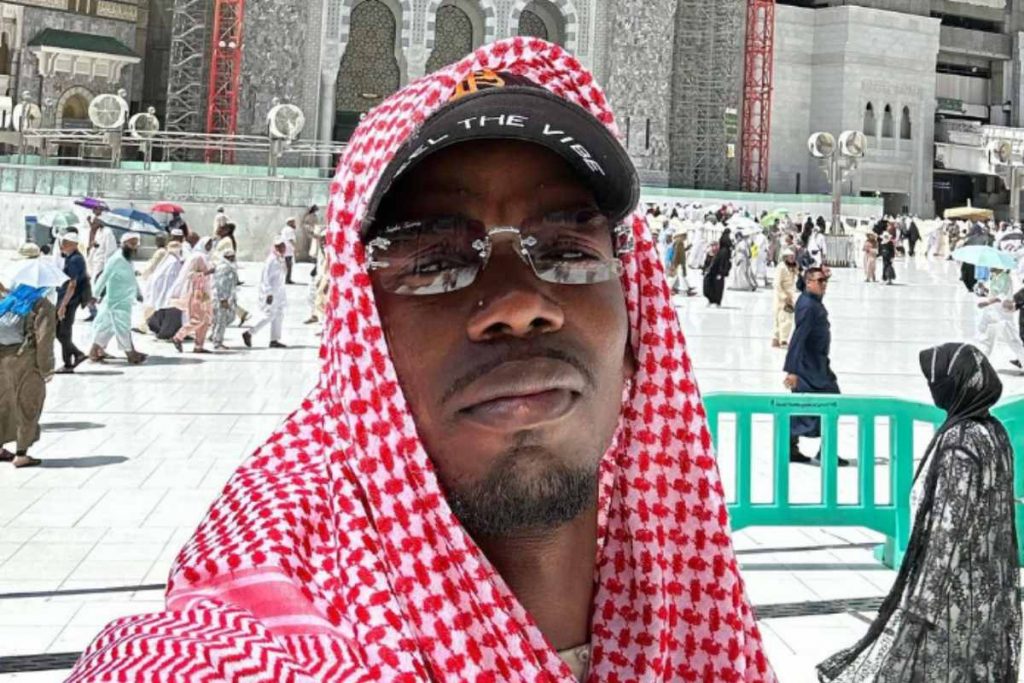curiosità
Questo animale è praticamente immortale: vive sulla nostra Terra da 66 milioni di anni. La scoperta
Un animale praticamente immortale che vive sulla nostra Terra da sempre: non immaginerete mai di chi stiamo parlando. La natura e, in particolare, il mondo …
leggi tutto…Pochi sanno il reale motivo per cui nei supermercati c’è sempre la musica: occhio a non cadere nella trappola
Nei negozi e nei supermercati viene quasi sempre messa della musica in sottofondo, ma sai qual è il vero motivo di questa scelta? Anche se …
leggi tutto…Acquisto nuova casa: prima di firmare il contratto fai queste 3 domande, ti salvano la vita
L’acquisto di una nuova casa è un passo importante. Ma prima di firmare il contratto ci sono 3 domande da fare per non commettere errori. …
leggi tutto…Spettacolo e Gossip
lifestyle

Quanto costa costruire una piscina interrata e tutto quello che c’è da sapere sulle caratteristiche
La piscina interrata è il sogno di molti, soprattutto d’estate è una delle idee migliori per godere di un po’ di fresco anche a casa. …